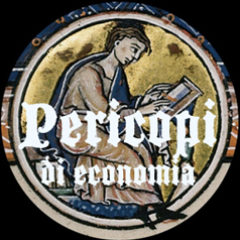Gli interessi aziendali hanno influenzato con successo anche il nostro linguaggio.
Ci riferiamo alle rivendicazioni sui brevetti e i copyright come a diritti di proprieta’ intellettuale, elevando questa forma di proprieta’ a diritto. E’ come se le aziende suggerissero che limitare la proprieta’ intellettuale fosse una privazione di liberta’ affine alla limitazione di altri diritti che teniamo cari […]
Il capitalismo incoraggia l’egoismo e il materialismo; l’egoismo spietato spesso conduce alla disonesta’; la disonesta’ mina la fiducia; e una mancanza di fiducia mina il funzionamento del sistema economico […]
Un incontrollato materialismo a livello globale da’ come risultato un’economia mondiale che non rimane all’interno dei confini delle risorse planetarie, eppure non siamo in grado di raggiungere la coesione sociopolitica necessaria a limitare il materialismo a sufficienza per rientrare entro quei confini […]
C’e’ ancora un altro aspetto del capitalismo […] si puo’ sostenere che il capitalismo, con il suo modo di plasmare le persone, le privi di gran parte della loro liberta’ di agire.
Quel che accade con il capitalismo e’ simile a quanto accade in alcune societa’ tradizionali, in cui ognuno conosce quale ruolo debba e sia obbligato a occupare nella societa’. Se una persona devia da quel ruolo, le sanzioni sociali sono enormi, al punto che le deviazioni avvengono di rado. Certo, all’interno del proprio ruolo ben definito, c’e’ qualche grado di liberta’ […]
Se una persona scegliesse di non agire da capitalista, perderebbe la propria identita’ e il proprio senso di se’ […]
Vivere in una casa piu’ piccola, in un quartiere meno ricco, danneggerebbe la loro identità di capitalisti di successo e potrebbe persino minarne la credibilita’ nei confronti degli altri capitalisti e di conseguenza il loro successo negli affari. In questo senso, i capitalisti percepiscono di avere scelte limitate e cio’, in una certa misura, e’ vero.
Info:
https://sbilanciamoci.info/stiglitz-il-neoliberalismo-e-un-fallimento/
https://ilpontedem.it/2024/06/22/joseph-e-stiglitz-la-strada-per-la-liberta-economia-e-buona-societa/
https://www.milanofinanza.it/news/la-lezione-del-nobel-joseph-e-stiglitz-un-capitalismo-progressivo-per-una-societa-giusta-202309152206147720
https://www.open.online/2024/11/22/il-premio-nobel-stiglitz-per-litalia-conseguenze-pessime-dalla-firma-del-patto-di-stabilita/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2024/11/22/il-nobel-per-leconomia-stiglitz-la-ue-e-tornata-allausterita-con-donald-paghera-due-volte/7776961/