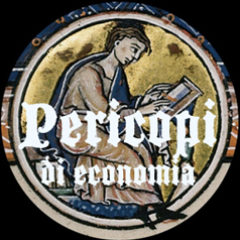L’esempio più significativo del tipo di problema con cui ci confrontiamo oggi si presenta in una forma che molti potrebbero considerare un semplice tecnicismo: il processo di privatizzazione.
Negli ultimi trent’anni, il culto della privatizzazione ha estasiato i governi occidentali (e molti governi non occidentali).
Perché? La risposta piu’ breve e’ che, in un periodo di vincoli di bilancio, la privatizzazione apparentemente permette di risparmiare denaro.
Se lo Stato possiede e gestisce un programma pubblico inefficiente o un servizio pubblico costoso (un acquedotto, una fabbrica automobilistica o una ferrovia), cerca di scaricarlo su acquirenti privati. La cessione permette allo Stato di incassare denaro e, al contempo, il servizio o l’attività in questione, entrando a far parte del settore privato, diventa piu’ efficiente grazie all’incentivo del profitto. Tutti ci guadagnano: il servizio migliora,lo Stato si libera di una responsabilita’ inopportuna e mal gestita, gli investitori realizzano profitti e il settore pubblico ricava un guadagno una tantum dalla vendita.
Questa e’ la teoria.
La pratica e’ ben diversa […] Quasi tutte le cose che i governi hanno ritenuto opportuno trasferire al settore privato operavano in perdita: che siano compagnie ferroviarie, miniere di carbone, servizi postali o societa’ elettriche, i costi di esercizio e di manutenzione sono superiori agli introiti che possano mai sperare di ottenere.
Proprio per questo motivo, tali beni pubblici risultavano poco interessanti per gli acquirenti privati, a meno di offrirli a prezzi fortemente scontati. Ma quando lo Stato svende i propri beni, e’ la collettivita’ a subire una perdita […]
In secondo luogo, si presenta il problema dell’azzardo morale. L’unico motivo per cui gli investitori privati sono disposti ad acquistare beni pubblici chiaramente inefficienti e’ che lo Stato riduce o elimina la loro esposizione al rischio […] facendo cosi’ venire meno la giustificazione economica classica della privatizzazione, cioe’ che l’incentivo del profitto favorisce l’efficienza.
L’«azzardo» in questione e’ che il settore privato, in queste condizioni privilegiate, si dimostri almeno altrettanto inefficiente della sua controparte pubblica e intanto intaschi gli eventuali profitti realizzati e addebiti le perdite allo Stato.
Il terzo argomento, e forse il piu’ efficace, contro la privatizzazione e’ il seguente.
Non ci sono dubbi sul fatto che molti beni e servizi che lo Stato cerca di dismettere siano stati gestiti male: in maniera incompetente, senza investimenti adeguati e cosi’ via. Ciononostante, per quanto mal gestiti, i servizi postali, le reti ferroviarie, le case di riposo, le carceri e altre attivita’ destinate alla privatizzazione restano sotto la responsabilita’ delle autorità pubbliche. Anche dopo essere state cedute, non possono essere totalmente abbandonate ai capricci del mercato. Sono, per loro stessa natura, un tipo di attivita’ che qualcuno deve regolamentare. […] Con ogni probabilita’ la verifica vera e propria sara’ eseguita da una societa’ privata, che ha vinto l’appalto per svolgere il servizio per conto dello Stato […]
I governi, in breve, affidano le loro responsabilita’ ad aziende private che promettono di amministrarle meglio dello Stato e a costi inferiori […]
Svuotando lo Stato delle sue responsabilita’ e capacita’, ne abbiamo indebolito l’immagine pubblica […]
Se operiamo esclusivamente o in misura preponderante con organismi privati, nel corso del tempo allentiamo i nostri rapporti con un settore pubblico del quale apparentemente non sappiamo cosa farcene.
Non e’ molto importante che il settore privato faccia le stesse cose meglio o peggio, a un costo maggiore o minore. In ogni caso, la nostra lealta’ verso lo Stato si attenua e perdiamo qualcosa di vitale che dovremmo condividere – e che in molti casi un tempo condividevamo – con i nostri concittadini.
Questo processo e’ stato ben descritto da una grande esperta moderna in materia: Margaret Thatcher, la quale, stando a quel che si dice, avrebbe affermato che «non esiste una cosa chiamata societa’. Esistono solo singoli uomini e donne e le famiglie». Ma se non esiste una cosa chiamata societa’, soltanto gli individui e lo Stato in veste di «custode notturno», che controlla a distanza attivita’ nelle quali non svolge alcun ruolo, che cosa ci legherà gli uni agli altri?
Info:
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858126479
https://ilmanifesto.it/tony-judt-e-la-responsabilita-della-storia/