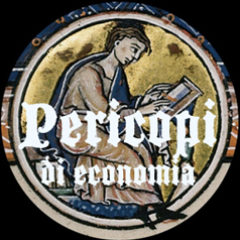Nel 2008 una crisi finanziaria, inizialmente quasi impercettibile e poi inarrestabile, ha innescato in Europa quella che e’ diventata una crisi prima economica e poi sociale.
Tutte le crisi prima o poi passano: ma, nel valutare un sistema economico, cio’ che conta non e’ che la crisi sia finita, ma il tempo che ci vuole per arrivare a una completa ripresa, le sofferenze inflitte tanto a lungo ai cittadini e la vulnerabilita’ del sistema a un’altra crisi.
In Europa le conseguenze della crisi finanziaria e della recessione sono state inutilmente gravi, lunghe e dolorose. Il divario tra la condizione attuale dell’economia e quella in cui si sarebbe trovata in assenza di crisi si misura ormai in trilioni di euro. E ancor oggi, un decennio dopo lo scoppio della crisi, la crescita rimane anemica e fragile.
Il fenomeno che meglio di ogni altro compendia gli effetti della crisi finanziaria del 2008 e’ la disoccupazione, che e’ aumentata in quasi tutti i paesi, e in alcuni di essi ha raggiunto livelli vertiginosi.
Dieci anni dopo, in gran parte dell’Unione la disoccupazione rimane inaccettabilmente alta, ma i leader europei continuano a preoccuparsi degli eventuali costi futuri dell’aumento del debito e del disavanzo in molti paesi, e a disinteressarsi delle conseguenze devastanti della crisi per tanti europei […]
Oggi un gran numero di giovani non ha alcuna possibilita’ di trovare un lavoro sicuro o gratificante in linea con le proprie capacita’ e aspirazioni: tra coloro che hanno meno di 25 anni, e quelli che non hanno completato gli studi secondari superiori, il tasso di disoccupazione medio europeo e’ il doppio di quello complessivo: rispettivamente 18,5 e 17 per cento.
E’ stato un decennio di occasioni perdute, nel corso del quale la disoccupazione di massa e’ diventata causa e al tempo stesso effetto della disuguaglianza. Molti lavoratori anziani che avrebbero potuto continuare a dare un contributo alla societa’ non ne hanno avuto la possibilita’; i giovani hanno dovuto fare a meno di quella prima fase di sviluppo delle competenze che e’ essenziale per la loro formazione e che incidera’ sulla loro crescita.
Info:
https://www.linkiesta.it/2020/05/nobel-stigliz-come-riscrivere-economia-europea/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/al-capezzale-dell-europa/
https://www.ilsaggiatore.com/libro/riscrivere-leconomia-europea/