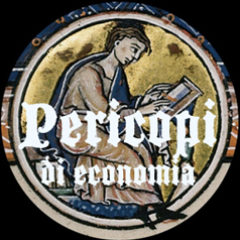Sono due i nodi principali che le diplomazie europee non sembrano riuscire a sciogliere.
Uno e’ di prospettiva e l’altro di metodo.
Il primo: siamo abituati a declinare la «questione africana» in chiave soprattutto emergenziale, vale a dire che ne affrontiamo i problemi – il terrorismo jihadista, lo sfruttamento delle risorse, i flussi migratori – solo quando bussano anche alla nostra porta.
Mancano una visione olistica, d’insieme e una vera pianificazione non solo contingente. Altri, molto più spregiudicati, occupano gli spazi che lasciamo liberi e ne traggono vantaggio, spesso scaricando le conseguenze su di noi.
Il secondo nodo e’ la carenza di pragmatismo, a cui fa da contraltare l’insistenza nel voler riproporre in Africa modelli che non possono funzionare al di fuori del mondo occidentale. «Condizionalita’»: ecco la parola che piu’ di tutte fa venire l’orticaria ai leader africani quando siedono al tavolo con i grandi d’Europa.
Non c’e’ finanziamento, cooperazione commerciale o di sicurezza di uno Stato europeo che non la contenga.
Clausole di ogni genere come precondizione perche’ la collaborazione possa svilupparsi. Il rispetto dei diritti umani. Le riforme economiche e sociali. La lotta alla corruzione, l’indipendenza del sistema giudiziario. O ancora, la tutela dell’ambiente e della biodiversita’.
Intendiamoci: cause sacrosante. Ma spesso decontestualizzate e ridotte a lacciuoli legali e formule di maniera, a cui appendere l’intesa politica con gli Stati africani.
E’ un problema e iniziamo solo oggi, in ritardo, ad accorgercene.
Alle orecchie dei capi di Stato e di governo africani tutte queste «condizionalita’» suonano come imposizioni, peraltro intrise di una lezione morale poco praticabile: se volete lavorare con noi, dovete diventare come noi […]
Il caso della Tunisia e’ eloquente: per mesi l’Europa ha cercato di trattare con Kais Saied, l’eccentrico presidente tunisino a capo di un Paese divenuto epicentro dei traffici di migranti nel Mediterraneo.
E piu’ di una volta le richieste di Bruxelles sul rispetto delle minoranze e le riforme del lavoro, in un Paese che ragiona con categorie completamente diverse, hanno rischiato di far saltare il tavolo. Per il rais di Tunisi, come del resto per i tanti leader del Global South che abbiamo citato, sono consigli non richiesti o, peggio ancora, imposizioni di Stati occidentali che si atteggiano a detentori della verita’.
Info:
https://www.pandorarivista.it/articoli/realpolitik-di-giampiero-massolo-e-francesco-bechis/
https://www.agi.it/estero/news/2024-05-30/libri-realpolitik-massolo-attrezzarsi-per-un-mondo-anarchico-26583006/
https://www.ilmessaggero.it/libri/realpolitik_il_libro_che_mette_ordine_al_disordine_mondiale-8109413.html
https://formiche.net/2024/06/recensione-di-realpolitik-massolo-bechis/#content